Perché voglio ricordare ai napoletani sparsi per l'Italia e sopratutto nel Nord, che vergognarsi di parlare la propria lingua significa il rinnegare le proprie origini.
Perché voglio che gli italiani delle altre regioni e sopratutto quelle del Nord, si rendano accettino finalmente l'idea che il Napoletano é una lingua - e una lingua viva, perbacco! - e chi non vuole capire questo e non intende riconoscerne l'importanza, commette un grave errore e perpetra un ulteriore enorme danno alla storia.
Immagine 1
Il Napoletano andrebbe studiato nelle scuole come lingua aggiuntiva e occorrerebbe farlo necessariamente almeno nell'ambito delle regioni che strutturavano il territorio del Regno delle Due Sicilie per evitarne l'imbarbarimento e la travisazione sia del parlato che dello scritto.
Personalmente mi vanto di parlarlo e di usarlo ogniqualvolta ne individuo l'occasione, lo utilizzo quando scrivo qualcosa che meriti di essere rappresentato nella mia lingua d'origine: cosa che mi piace fare con molta gioia; ho cercato di studiarne la grammatica applicandone sistematicamente le regole nella speranza di non aver commesso e non commettere molti errori: gli autodidatti hanno il problema di non avere chi li guida e corregge; hanno la presunzione, spesse volte mal riposta, di essere maestri di sé stessi.
Ma tant'è: dove iscriversi a un corso di lingua napoletana ormai?
Lo scorso anno, si era forse in marzo? era magari già aprile?
Un giovane che conosco, e ne conosco bene anche i genitori più altri suoi parenti diversamente posizionati nella scaletta della gradualità di discendenza, sarebbe andato sposo in maggio e costruì un sito a uso di amici, parenti e conoscenti affinché ciascuno vi leggesse un po' di storie e inserisse un qualcosa di personale affinché gli sposi potessero poi ripercorrere l'evento attraverso i pensieri e i racconti dei partecipanti all'evento.
Fui ispirato ancorché sollecitato a esserlo, nella costruzione di un acquerello che sintetizzava insieme invenzione e realtà.
Una breve piccola immagine giocosa.
Immagine 2.
Quella che cerco di studiare da anni e che uso dunque quando intendo creare intimità con chi leggerà, confermandogli affetto e simpatia per quanto magari ignoto.
Ebbene quel piccolo siparietto scomparve nel breve volgere di qualche ora se non minuti, e
piuttosto che ricevere una telefonata partecipante buon umore come mi attendevo dall'altro capo della linea telefonica una accorata voce tremando e inorridita per l'azzardo rilevato, mi chiedeva se fossi per caso proprio io il responsabile di quello scritto, immaginando un tremendo scherzo da parte di uno sconosciuto.
Come avevo mai potuto pensare di fare una cosa del genere!
Scrivere in un linguaggio così volgare e popolano!
Cosa avrebbero mai detto se lo avessero letto - e speriamo che sia stato eliminato per tempo! - Tizio, Caio e Sempronio che non avrebbero potuto far altro che chiedersi con chi mai avesse a che fare quel ragazzo che aveva dato loro fino a quel momento una così limpida e lodevole impressione.
Da quale vile strato sociale sarebbero mai giunti i suoi parenti e amici!
Avevo messo tutti in difficoltà! Tutti additati al pubblico ludibrio!
Eppure si trattava di napoletani: tutti! Dal primo all'ultimo.
Gli sposi, i loro parenti di vario ordine e grado, la gran parte dei loro amici; su questi ultimi non saprei ben dire, ma poco importa.
Un gruppo di napoletani che come tanti altri come loro usano fare, rinnegano le proprie origini nella speranza che non si riconosca la loro provenienza.
Immagine 3
 Un gruppo di napoletani che come tanti altri come loro non vogliono avere conto che il Napoletano è parimenti una lingua come l'italiano; anzi: questa sicuramente volgare, quella invece originaria.
Un gruppo di napoletani che come tanti altri come loro non vogliono avere conto che il Napoletano è parimenti una lingua come l'italiano; anzi: questa sicuramente volgare, quella invece originaria.
Ma tant'è: in genere i napoletani son fati così.
Subito pronti a osannare chi arriva da fuori non ritenendo possibile che nella propria casa possa nascere qualche cosa di buono. Immagine 4
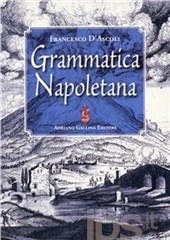
Io mi vanto di essere napoletano, di parlare e scrivere in napoletano: quello vero, quello che è "lingua vera" non frutto di imbarbarimento.
Penso di avere il vantaggio rispetto ai popoli delle altre regioni, di appartenere a una terra
gloriosa con un passato ricco di storia e cultura.
E grazie a questo e al non rinnegare né l'una né l'altra, sono anche io stesso un piccolo sassolino nella storia della cultura napoletana.
******************
La lingua Napoletana, patrimonio dell’Unesco
di Angelo Forgione.
L’Unesco riconosce il napoletano come lingua, e non dialetto, seconda solo all’italiano per diffusione tra quelle parlate nella penisola.
Sicuramente si tratta dell’idioma italico più esportato e conosciuto grazie alla canzone classica partenopea, una delle maggiori espressioni artistiche della cultura occidentale che da più di un secolo diffonde in tutto il mondo la bellezza della parlata napoletana.
Una lingua romanza che, nelle sue variazioni, si parla correntemente nell’alto casertano, nel sannio, in irpinia, nel cilento, e nelle zone più vicine di Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, ovvero tutti quei territori che nelle antiche Due Sicilie costituivano il Regno al di qua del faro di Messina laddove la lingua nazionale era appunto il Napolitano, mentre il Siciliano era la lingua nazionale del Regno al di la del faro (Sicilia).
Nonostante la meritoria e imponente opera dei grandi scrittori e compositori di musica napoletana classica, dal 1860 in poi, con la perdita d’identità del popolo meridionale, il Napoletano è però purtroppo andato sempre più degradando e oggi si sta trasformando volgarmente per molteplici cause.
Prima fra tutte la mancata valorizzazione e il negato insegnamento che stanno mistificando la grammatica e la pronuncia di questa meravigliosa lingua riconosciuta dall’Unesco ma non dallo stato italiano.
Di qui, dunque, l’aggressione delle contaminazioni moderne fatte di un volgare slang giovanile e di vocaboli stravolti nel significato.
Ad esempio, un vocabolo come “vrénzola”, ossia “cosa da poco (sta ascénno ‘na vrenzola ‘e sole), è stato tristemente trasformato in indicazione di donna volgare.
Iniziative a tutela provano a metterle in piedi timidamente le istituzioni locali e nella seduta del 14 Ottobre 2008, il Consiglio Regionale della Regione Campania approvò un disegno di legge d’iniziativa provinciale sotto titolo “Tutela e valorizzazione della lingua napoletana”.
La risoluzione attende però di trovare il suo seguito con adatte soluzioni strutturali che permettano ai più giovani di imparare grammatica, ortografia e dizione corrette.
Provate a chiedere a un napoletano, per esempio, la differenza tra apostrofo e aferesi, elementi cardini della scrittura partenopea.
Provate a chiedere a un napoletano, per esempio, la differenza tra apostrofo e aferesi, elementi cardini della scrittura partenopea.
Probabilmente resterà muto al sentire la seconda, ovvero quel segno diacritico che deve precedere un articolo determinativo.
E qui si presenta il più frequente degli errori di scrittura oggi ravvisabili sulle insegne e sui manifesti pubblicitari in napoletano: l’articolo “il”, che si traduce in “lo” per poi divenire tronco ponendovi l’aferesi, appunto, che ne cancella la consonante iniziale, viene frequentemente scritto o’, con l’apostrofo dopo la o che segnala un’elisione inesistente, mentre andrebbe scritto ‘o, con l’aferesi che invece cancella la consonante iniziale e la sua pronuncia nella parola.
È un piccolo ma significativo esempio a cui a cascata ne potrebbero seguire tantissimi.
E allora, per dare un senso didattico a questo scritto, prendo a spunto un’insegna (vedi foto), come tante se ne vedono al centro di Napoli, che è l’esatta fotografia di questa perdita di patrimonio linguistico.
Immagine 5
Vi si legge “A’ TAVERNA DO’ RÈ”, e chi conosce e ama la lingua di Partenope non può non trasalire.
Sei errori sei in una sola stringata frase! Va detto subito che la forma grammaticale napoletana corretta è: ‘A TABERNA D’ ‘O RRE. E vediamo perché.
Come detto, l’articolo determinativo “la” diventa tronco e vi si pone l’aferesi che cancella la consonante iniziale, non l’apostrofo dopo la a.
La parola “Taverna” in Napoletano è più correttamente tradotta in “Taberna”, vocabolo derivante dalla lingua spagnola; ma questa è poca cosa di fronte alla preposizione articolata “del” che in napoletano diventa “d’ ‘o”, ovvero “de lo” in cui si pone l’apostrofo dopo la d che sancisce l’elisione della o e la dizione tronca, nonchè l’aferesi prima della o (vale il discorso dell’articolo “la”).
Infine, in molti casi, l’articolo determinativo singolare maschile fa raddoppiare la consonante della parola che segue per indicarne e sottolinearne la dizione corretta, come nel caso di “il Re” che diventa ‘o Rre e non ‘o Ré con una sola erre e con l’improprio accento sulla e.
Insomma, un’insegna che non insegna ma disorienta e che fa tristezza pensando a quanto valga la nostra lingua e cosa significhi per la nostra cultura identitaria, che non è seconda a nessuno nel mondo.
Ai meno superficiali non resta che andare in libreria e dotarsi di testi di grammatica napoletana o spulciare in internet dove è possibile recuperare piccoli ma utilissimi saggi. Si salvi chi vuole, dunque, e trasferisca poi ai propri figli.
Immagine1: Fonte Web.
Immagine 2: Fonte Archivio personale.
Immagine 3: Fonte https://archive.org/details/GrammaticaDelDialettoNapoletano
Immagine 4: Fonte Ibs.it - http://www.ibs.it/code/9788895142050/d-ascoli-francesco/grammatica-napoletana.html
Immagine 5: Fonte Napoli.com-Quotidiano online della città. - http://www.napoli.com/viewarticolo.php?articolo=34942 - Anno XII - N°342 - 8 Dicembre 2014



Nessun commento:
Posta un commento